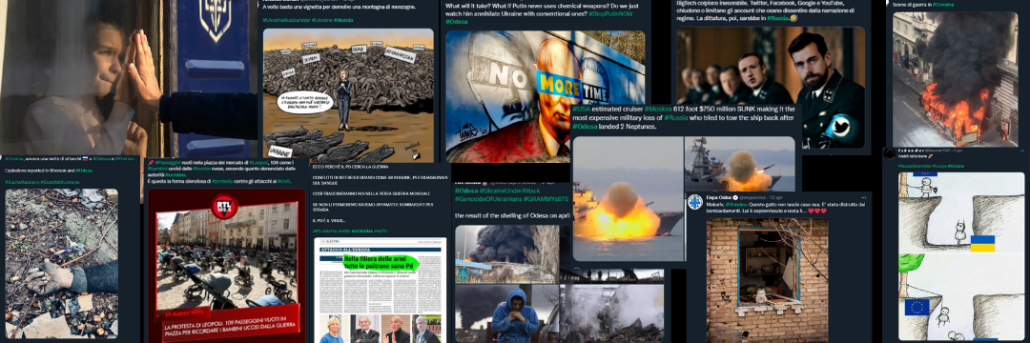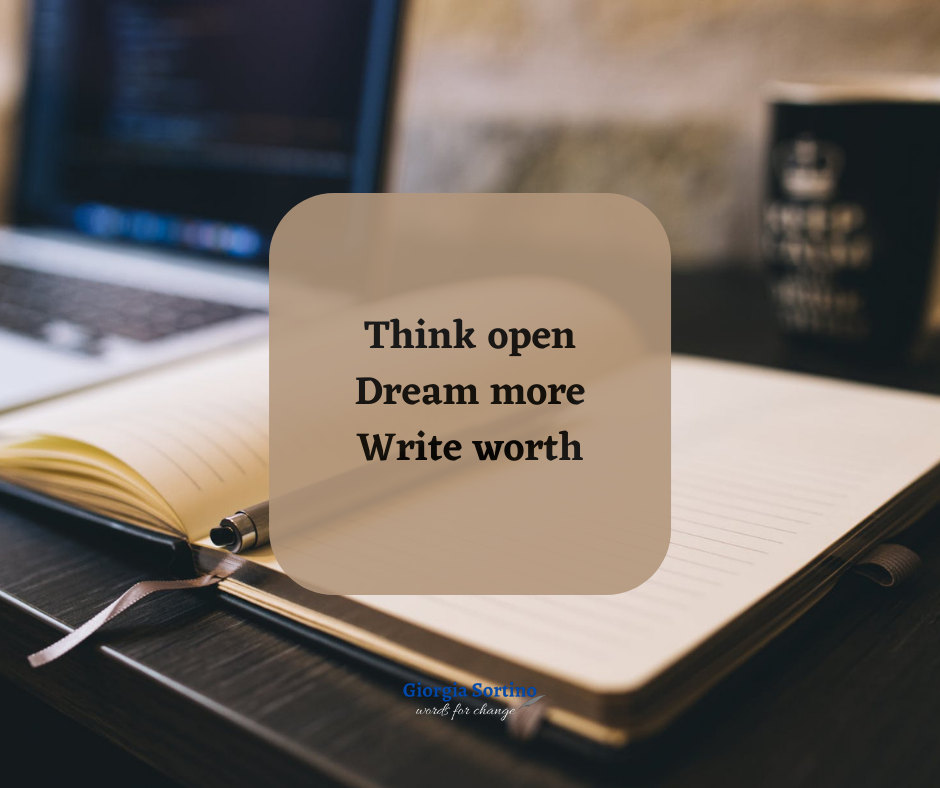Ogni 31 dicembre, quando si compie il fatidico countdown per annunciare l’arrivo del nuovo anno, si spera sempre in meglio non è vero? È successo quando ci si lasciava alle spalle il complicato 2020 e si guardava al 2021 con occhi speranzosi di tornare alla normalità di quel “pre-covid”: non vedevamo l’ora di scalciarci alle spalle il 2020, sperando di trovare di meglio, ma così non è stato. Abbiamo, però, imparato a convivere – o quasi – con una nuova prassi da eseguire quando si sta in mezzo agli altri. È stato difficile, per alcuni più che per altri, e lo è tutt’ora, dal momento che la pandemia ha cambiato tante cose, ma si è andati avanti.
Al termine del 2021 è successa la stessa cosa. Eravamo speranzosi, magari non tutti ma in parte lo eravamo, di trovarci davanti un anno in discesa o quantomeno quieto perché il mondo aveva ed ha bisogno di tranquillità e collaborazione per leccarsi le ferite lasciate dalla pandemia. Ci è passato in qualche modo per la testa che si sarebbe andati a migliorare – “ok, il 2021 è stato comunque meglio del 2020, quindi il 2022 andrà meglio, no?”. No.
Un vezzo d’ingenuità ed ottimismo dell’essere umano o, forse più specificatamente, di quelli di noi che tutto sommato hanno ancora fede nell’umanità e guardano al mondo con filtri meno bui.
Illusi, voi direte. Beh, forse. O magari c’è che se non si fa così, se non si trova il modo di sperare o non si ha qualcosa in cui credere, tutto diventa più difficile. E quindi… ci si scava dentro, si guarda alle cose belle che si hanno nella vita, per convincersi di avere fede nel futuro. Di avere fede nella gentilezza, nell’amore, nell’arte che ispira e che forse tutte queste possono essere la cura del cancro che ci attanaglia: l’odio, l’avidità, il bisogno di autoaffermazione ai danni dell’altro – fratello degenere dell’orgoglio -, l’individualismo, l’egoismo, il razzismo, l’elitarismo, la misantropia e la misoginia, il menefreghismo, lo sfruttamento e… forse è bene che mi fermi qui, ma sicuramente troverete altre patologie croniche dell’anima che ci affliggono.
Poi, però, il 24 febbraio 2022 ti svegli e scopri che non è così. Non è mai così. Che forse hai davvero mal riposto la tua fiducia nel futuro, nell’umanità, nella gentilezza. È il coperchio del vaso di Pandora che si rompe, lasciando scivolare al di fuori tutti i mali. Non che prima non ve ne fossero, bisognerebbe essere ciechi per sostenere il contrario, ma da adesso sembra che quei mali si siano condensati e concretizzati tutti in una parte del mondo ben precisa. Adesso è come quando improvvisamente una parte del nostro corpo fa molto male, ci si rivolta contro, e il medico ci chiede dove il dolore è localizzato.
Quel giorno preciso – il 24 febbraio 2022 – tutto quello che elencavo sopra ha spinto un uomo a credere che fosse lecito o accettabile distruggere e devastare un paese, uccidere, decimare e annientare un popolo. Se ne sono dette tante in merito per cercare di comprendere i motivi che hanno spinto Putin a dare inizio a questa follia e il mondo si è spaccato metaforicamente parlando e non.
– Che l’abbia fatto per riportare la Russia all’antica gloria dell’URSS;
– Che l’abbia fatto per cacciare i nazisti dall’Ucraina;
– Che l’abbia fatto per restituire l’indipendenza a quelle regioni che non erano concordi con l’assetto assunto dall’Ucraina;
– Che l’abbia fatto per dimostrare agli Stati Uniti e alla NATO che lui non teme nessuno e che farebbero bene a rispettare gli accordi presi in precedenza;
– Che l’abbia fatto per il complesso dell’ubermensch
Qualsiasi motivo che l’abbia spinto a cominciare questa guerra, in condizioni normali e men che meno all’indomani di una pandemia, non ha importanza. Nessuna ragione può valere tutto ciò che sta accadendo: i danni arrecati al pianeta, già sofferente tra le altre cose; le innocenti vite umane dissolte e, in troppi casi, consumate prima ancora che cominciassero; le preziose risorse sperperate.
La generazione dei Millennials specialmente, ma anche chiunque sia nato dopo la metà del secolo scorso, in parti del mondo che tutto sommato hanno vissuto fino ad ora in pace o sono stati indirettamente interessati a vicende spinose – basti pensare agli eterni conflitti dei paesi arabi – ha percepito la parola “guerra” e tutti i racconti annessi come – purtroppo devo dirlo – quasi leggende. Non siamo certo ciechi alle atrocità del mondo, rimaniamo allibiti quando nel feed dei nostri social compare qualche notizia su un attacco terroristico in metropolitana ad esempio. Quindi, leggiamo la news, riflettiamo per qualche minuto, poi la nostra quotidianità ci distrae nuovamente e finisce lì. Nel mondo continua ad esserci A che odia B, B che colpisce per primo A perché “l’attacco è la miglior difesa, si sa”, e cadavers che si accumulano su altri cadaveri mentre noi siamo tornati alla nostra vita. Succedeva perché, nonostante internet e l’informazione rapida abbiano accorciato le distanze, è vero anche che finché non si vivono sulla propria pelle certe cose è difficile comprenderle realmente.
Sento dire che la guerra si combatte e si vince sui campi di battaglia, ma… quali sono? Sono le strade di Kyiv in cui fino al giorno prima sfilavano le auto di famiglie ignare di ciò che sarebbe successo poche ore dopo; sono le case in cui quelle stesse famiglie rientravano verso sera. Sono le scuole di Mariupol in cui ci si adoperava per festeggiare l’arrivo della primavera, senza sapere che il 21 marzo sarebbe presto diventato un futuro troppo incerto per alcuni e l’irrealizzato per tanti altri. Sono gli ospedali di Odesa, fra le cui mura bianche qualcuno lottava già per la sopravvivenza. Sono i musei, i teatri, i cinema, le librerie, le gallerie d’arte dove si conservava ed offriva la parte migliore dell’umanità. Quindi, esattamente, cos’è un campo di battaglia? È tutto ed è niente, direi io, nella misura in cui prima d’essere palcoscenico di uno scontro era tutto – un parco dove i bambini giocavano, una clinica in cui si salvavano delle vite, un centro di accoglienza per i poveri – e poi è stato ridotto in nulla. Polvere, macerie, cenere.
Ad oggi, però, mi sento di dire che la guerra è anche in rete e sui social. È la guerra dell’opinione pubblica, stordita e confusa, dalle più disparate notizie. Senza senso, contraddittorie, imprecise, parziali, incongruenti, crude, scombussolanti, disturbanti e chi più ne ha più ne metta.
Entro su Twitter, il metodo a mio avviso più immediato per trovare delle news (#kyiv #kiev #mariupol #ukraine #ukrainewar #stopwar #putin, ecc…), e trovo di tutto oltre gli aggiornamenti in tempo reale di ciò che accade.
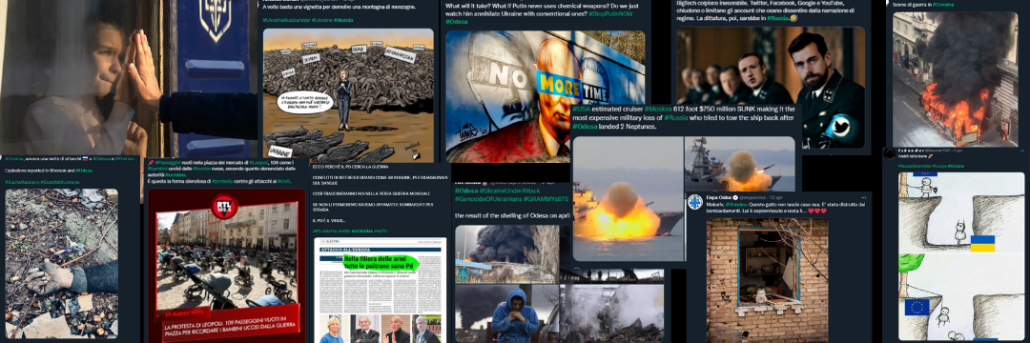
Insomma, si trova di tutto ed è sconcertante.
Dalla news di cronaca nera corredata di foto shock, che viola almeno uno dei principi giornalistici della cronaca, allo humour caustico di chi ha un buco nero al centro del petto fino ai conflitti di opinione espressi con convinzione e ferocia da lasciarmi perplessa e turbata quasi quanto la decisione di Putin di invadere l’Ucraina: l’opinione pubblica fa letteralmente a pugni e trova così facile schierarsi da un lato o dall’altro, che a questo punto io mi sento… beh, stupida perché fondamentalmente non credo sia utile farlo.
Non riesco a schierarmi pensando di stare da una parte o dall’altra e non perché io consideri l’invasione russa legittima, sia chiaro. Non riesco a schierarmi perché, nel corso degli anni di studio in cui mi è stata riproposta in diverse salse e prospettive la storia dell’Europa e del globo, ho capito che è complesso stabilire cose come: antefatti, cause, verità, cronologia degli eventi, azioni e conseguenze.
C’è chi non ha mai smesso di raccontarsi la storia a modo proprio e chi invece ha dato per buona la versione di una o dell’altra parte perché conveniva così, ma la verità spesso sta in mezzo e credo sia così anche adesso. Magari la mia è una unpopular opinion, ma è la mia ed io credo in questo; osservo ed ascolto ciò che mi circonda, mi informo e poi rifletto: la mia logica mi suggerisce che non è semplice. Non lo è mai, in questo caso ancora meno.
Non riesco a schierarmi perché sono consapevole che esista la propaganda, le notizie che giungono sono filtrate in nome dell’utilità e chissà di cos’altro. Non riesco a schierarmi perché, in realtà, non penso sia importante nemmeno questo; quello che si è spaccato ancora una volta in fronti contrapposti dovrebbe invece essere un unico fronte: l’umanità. Unica ma non sola se unita, istupidita e devastata se divisa. La verità è questa. Istupidita e devastata perché divisa ancora una volta, così come in passato ma l’uomo tende a dimenticarlo a quanto pare.
Un’altra ragione d’odio e un altro picco, un’altra guerra e altra distruzione, nuove crudeltà e nuove assenze, nuove lezioni e nuove commemorazioni che nel tempo perderanno significato. E si ricomincerà. Errori in circolo.
Quando ci si dimentica delle atrocità della guerra, qualcuno salta sempre fuori a rinfrescare la memoria globale. Così si avrà un circolo vizioso in eterno, perché l’uomo non impara mai dai propri errori ma trova invece più semplice resettare il mondo, la storia e perfino la sua memoria.
Errori in circolo.